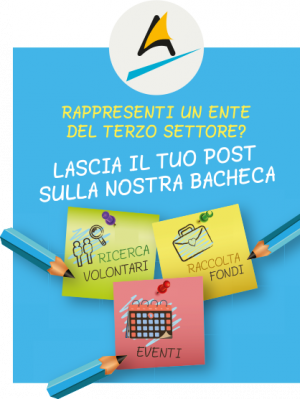di Rosi Pennino
PALERMO. Le Politiche Sociosanitarie (e ci tengo a definirle così, e non sociali e basta) e la sicurezza sono due aspetti fondamentali per garantire la stabilità sociale nelle città in generale e nelle grandi aree metropolitane in particolare.
Nessun pensiero né strategia efficace sulla sicurezza può prescindere dal fatto che tre sono gli assi paralleli da intersecare: rigenerazione urbana, politiche sociosanitarie di prossimità e presenza delle forze dell’ordine sui territori.
Tre anni da quello che io definisco “un osservatorio privilegiato” mi portano ad affermare con ampia serenità, che non vi è in atto un peggioramento delle condizioni della sicurezza in città, ma che certamente c’è un problema sicurezza e benessere dei cittadini che riguarda tutte le aree metropolitane del Paese.
Il confronto costante avuto in questi anni con gli altri Assessori delle città metropolitane mi ha infatti costantemente restituito il polso di come i fatti di Palermo siano quelli di Milano, Torino, Roma e di tante altre realtà che vivono il dimensionamento della faticosa ricerca di armonizzare centri e periferie, servizi e bisogni, giovani e famiglie, povertà e strumenti che mettano in atto strategie per la fuoriuscita da una condizione di marginalità economica, culturale e sociale.
Per queste ragioni, in più occasioni il coro unanime è stato quello di chiedere di mettere nelle disponibilità degli enti locali risorse più libere e meno vincolate, di modo da poter adattare le risposte ai bisogni reali di ogni città.
Questo non significa che non esista il problema sicurezza, piuttosto, invece obbliga a una riflessione di strategia comune che non può passare sbrigativamente attraverso l’affermazione qualunquista del “mandiamo l’esercito”. Diceva Gesualdo Bufalino, in una frase ripresa da Giovanni Falcone, che “per sconfiggere la mafia occorre un esercito di maestri elementari”, allo stesso modo per rimettere in cammino la giustizia sociale, il benessere dei cittadini e la qualità della vita in città occorre “un esercito di assistenti sociali, psicologi ed educatori”, una rete che esula perfino le esclusive competenze dell’ente locale e che può essere messa in campo attraverso un patto fortissimo di natura sociosanitaria dando vita al sistema integrato dei servizi, diffusi e presenti non su base circoscrizionale ma di quartiere.
Non sono bacchette magiche e neppure antidolorifico a effetto istantaneo, le azioni che si mettono in campo sul piano sociosanitario determinano cambiamenti lenti ma duraturi; perché, quando riescono a spezzare la condizione di marginalità, cambia il corso dell’esistenza di famiglie, generazioni di bambini e perfino il destino stesso di intere fette di città.
Da tecnico e da appassionata della materia sociosanitaria sento di affermarlo con serenità. Occorre avere una lettura chiara di alcuni fenomeni da cui partire:
- Il passaggio dal Reddito di Cittadinanza all’Assegno d’Inclusione ha dimezzato la platea dei percettori di aiuti economici (da 54mila su base rdc a 25 mila);
- La pandemia e lo stato di salute mentale di una intera generazione di giovani e delle loro famiglie;
- Il fenomeno massiccio delle dipendenze, tutte, non solo il crack di cui molto si discute, ma tutte le dipendenze, alcol in primis;
- Lo sgretolamento delle unioni familiari unito all’assenza di competenze genitoriali funzionali ad uno schema di riferimento valoriale con solidi punti di riferimento come lo era per i nostri genitori;
- Un sistema di opportunità che dalla politica (che dovrebbe dare l’esempio) al mondo del lavoro mortifica la Meritocrazia;
- Il dimensionamento delle circoscrizioni con la perdita di identità e di comunità che invece avevano i quartieri;
- Il sentimento diffuso dell’accettazione innanzi alle ingiustizie con la consequenziale perdita dei sogni.
Ad una prima lettura, questo può apparire il solito “pippone filosofico teso a pensieri dell’iperuranio”, ma non è cosi, perché questa è la cornice all’interno della quale mi sono mossa in tre anni, dedicando chiaramente il primo anno a una faticosa ricostruzione dello stato di salute delle risorse non spese, non programmate e di una presenza di assistenti sociali ormai ridotta al lumicino.
Il servizio sociale ha un ruolo e una missione fondamentale nei territori, a Palermo in soli sei mesi dall’insediamento nel 2022, ne sono stati stabilizzati 54, su base distrettuale, e altri 20 hanno firmato il contratto proprio l’ultimo giorno di aprile scorso; in parallelo sono stati riqualificati riconoscendo la funzione di psicologi a tutte quelle unità di personale che per anni non hanno potuto esercitare.
L’obiettivo era quello di riportare il servizio sociale sdoppiandolo in due sedi per ogni circoscrizione; per queste ragioni, dopo 23 anni, sono tornati ad avere sede nel cuore dello Zen 2 i servizi sociali, nessuno più di me può avere memoria del fatto che mancassero da 23 anni.
Questo ripopolamento del servizio sociale andava di pari passo a una battaglia a livello nazionale che in molti stanno portando avanti, quella di esautorare dalla pratica della domanda di Assegno d’Inclusione gli assistenti sociali, non solo perché mortifica il loro ruolo, ma anche perché l’ondata burocratica e numerica che anche questo settembre si ripresenterà, impedisce, immobilizzandolo, al servizio sociale di esercitare quella funzione e missione nei territori, di anello di congiunzione tra tutte le risorse del terzo settore e gli altri attori istituzionali quali la scuola, i consultori e i cittadini.
L’Assegno d’Inclusione dovrebbe solo essere lo strumento di lavoro che consente all’assistente sociale di agganciare tutte le opportunità di servizi alle famiglie e alle persone; ruolo che oggi è impossibilitato a svolgere.
La funzione sociosanitaria dei servizi, nulla di valido può essere messo in campo se non realizzato con il dialogo e il lavoro costante con la sanità, e quindi con la salute mentale.
I diversi tavoli con la salute mentale fatti di lavoro sul campo hanno consentito la spesa di oltre 7 milioni di euro per il contrasto alle dipendenze (prima Fuori dal Giro, poi i servizi a bassa soglia, lasciati pronti e in via di pubblicazione), ma anche di avere una mappatura e un piano di intervento reale di tutte quelle persone senza dimora, in condizioni di disagio psichico; invertendo quella tendenza della visione della persona povera a cui dare solo da mangiare e da dormire, frutto di una meritevole visione caritatevole che però mette pezze e non genera cambiamento.
Sulle azioni messe in campo potrei proseguire senza sosta, in considerazione del fatto che sono stati oltre 100 i milioni spesi e programmati in tre anni con picche di strumenti innovativi frutto di una bellissima sinergia con gli uffici di programmazione: il pronto intervento sociale, agenzia per l’inclusione, etc.
Tutta la programmazione è costruita e fermamente ancorata fino al 2027, ivi compresi i centri aggregativi di quartiere; si, uno per ogni quartiere, perché la chiave deve tornare a essere quella di risanare le ferite di quartieri che sono stati appiccicati per volontà di una ex riforma regionale, in unità circoscrizionali che mettono insieme lo Zen e Mondello, piuttosto che viale Strasburgo e il Cep.
Questi strumenti sociosanitari possono fare concretamente e gradualmente la differenza: avviare processi, invertire tendenze, restituire servizi e vicinanza con la presenza degli stessi. Non servono tavoli pletorici, ma metodo di lavoro sociosanitario, fatto di buone pratiche in ogni segmento che riguarda le fragilità. Deve diventare normale l’approccio integrato ai servizi, nonostante da un punto di vista normativo in Sicilia non sia stato completato il quadro delle competenze sociosanitarie, lasciando ancora una linea di differenza tra il socioassistenziale e il sanitario. Un ritardo che rispetto al resto del Paese ci fa pagare un prezzo altissimo in termini di qualità di servizi efficaci ed efficienti, e di armonizzazione delle risorse.