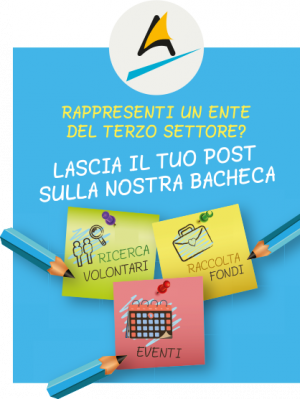SCIACCA. Si è concluso anche l’ultimo week-end del festival primaverile organizzato da “Le Vie dei Tesori”, svoltosi a Sciacca, dal 26 marzo al 10 aprile e che ha visto come protagonista Ferdinandea, “l’isola che (non) c’è”.
Visite a monumenti, passeggiate itineranti, videomapping, mostre, convegni, percorsi narrativi, si sono succeduti nel meraviglioso scenario della città termale di Sciacca, indissolubilmente legata alla ceramica, al corallo e al mare. E, proprio dal mare, nel luglio del 1831, sbucò letteralmente fuori l’isola Ferdinandea, in seguito a forti scosse telluriche che furono avvertite in tutta la Sicilia. Il vulcano sottomarino Empedocle eruttò un numero tale di detriti di lava da far emergere la sua bocca fin sopra il livello del mare, esattamente a 60 metri di altezza.

Quel periodo storico era caratterizzato dalla presenza di numerose flotte navali europee nell’area del basso Mediterraneo, che si rivelarono subito interessate a nuovi punti di approdo strategici, e fu così che l’isola Ferdinandea si ritrovò al centro di spinosi contrasti.
A fine agosto 1831, in seguito ad una ricognizione avvenuta poco tempo prima, il capitano della flotta inglese Jenhouse piantò bandiera britannica nel punto di altezza più alto, ribattezzando l’isola come Graham.
In realtà, quella terra sottomarina riemersa era stata vista per primo da due capitani dell’Impero Borbonico, Corrao e Trefiletti, facendo entrare in gioco anche il Regno delle Due Sicilie. Anche i francesi, in seguito ad una missione di studio dei materiali di cui era composta l’isola, avvenuta a luglio del 1831, pensarono bene di ritornare per contrastare gli interessi britannici, andando a piazzare anche loro una bandiera francese.

La questione, ben presto, diventò tutt’altro che semplice, facendo indispettire perfino re Ferdinando II, che inviò sul posto la corvetta bombardiera Etna guidata dal capitano Corrao, che fece piazzare una terza bandiera, quella borbonica, e dando all’isola il nome di Ferdinandea in onore del suo re.
Gli inglesi, non contenti, giunsero nuovamente in loco sotto la guida del capitano Jenhouse e il rischio di una guerra generale sembrò sfiorarsi ogni giorno di più, ma, con atto sovrano, Ferdinando rivendicò l’isola ed inviò memoria ai governi inglese e francese, affermando che, a norma del diritto internazionale dell’epoca, l’isola era… emersa in acque siciliane. Una situazione oggettivamente inusuale e curiosa!
I francesi, nel frattempo, avevano dirottato i propri interessi verso altre località, in quanto sarebbe emerso che l’isola fosse principalmente composta da tefrite, un materiale roccioso di natura vulcanica, andando velocemente incontro ad erosione. E, nei fatti, fu proprio così!
L’isoletta, quasi a voler sfuggire ad una singola potenza nello specifico, e al potere stesso, rivendicando una natura libertaria che appartiene in fondo a tutta la Sicilia, iniziò gradualmente a disgregarsi, fino a scomparire nuovamente sotto il livello del mare verso l’inizio del 1832. Lo spazio sottomarino sottostante fu chiamato dai cartografi dell’epoca Banco di Graham, termine identificativo ancora oggi utilizzato.
Le successive apparizioni dell’isola risultarono essere sporadiche e circoscritte a pochi giorni, quasi come se si avesse a che fare con un fantasma che alimentasse il suo stesso mistero, quasi come avere a che fare con una… Ferdinan-Dea.
Il microclima favorevole creatosi attorno all’attività del vulcano favorì, come per magia, la produzione di enormi distese coralline ed ecco che l’isola, pur non vedendosi neanche più, poté mantenere un legame con la terra e con gli esseri umani, e gli abitanti di Sciacca fecero esperienza dello splendido “corallium rubrum”.
I saccensi iniziarono lentamente a pescarlo e poi a lavorarlo, imparando dalla lunga tradizione degli artigiani di Torre del Greco e di Trapani, che da molti secoli ne avevano già dimestichezza.
Oggi esiste perfino il “Museo del Corallo Nocito”, e tanti sono i laboratori artigiani che contribuiscono alla cultura e all’economia cittadina anche attraverso l’esportazione, puntando il fatto sulla particolarità del colore di questo corallo che, avendo origine vulcanica, assume un colore che va dall’arancio intenso fino ad una tonalità quasi bruna.
Una città, Sciacca, letteralmente “votata” al mare, considerando anche il fatto che, durante la processione della Santa Patrona che esce dalla Chiesa Madre, la statua della Madonna del Soccorso faccia una sorta di inchino al mare, per poi proseguire il percorso.
Il fascino dell’isola Ferdinandea rivivrà anche attraverso un progetto immersivo multimediale del comune di Sciacca, che avrà futura sede all’interno del Museo del Mare, nel complesso monumentale Fazello. “Vogliamo dotare Sciacca, tramite il PNRR, di una nuova e moderna esperienza museale – affermano infatti il sindaco Francesca Valenti e l’assessore comunale alla Cultura Gisella Mondino –, che, coniugando tecnologia e narrazione, consentirà ai visitatori di immergersi nell’azzurro mare che abbraccia la Ferdinandea”.