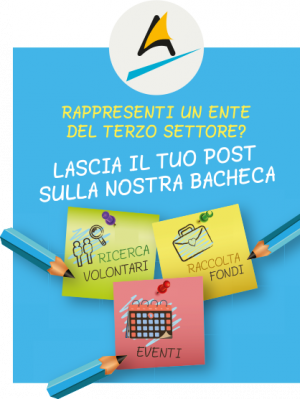di Rosi Pennino
PALERMO. Proviamo oggi a fare una riflessione sul ruolo delle Comunità alloggio per minori, su come e quanto questo tassello di accoglienza abbia contribuito a cambiare il modello organizzativo e tristemente inadeguato degli “orfanotrofi”, collegandosi all’evoluzione lenta ma importantissima di tutti i capisaldi normativi e sociali che hanno contribuito nella realizzazione di quel vasto panorama dei diritti legati all’infanzia e all’adolescenza.
Iniziamo con qualche cenno storico, brevissimo, che non fa mai male. Sono sempre stata dell’opinione, infatti, che per capire dove siamo, occorre ricordare sempre da dove si è partiti, altrimenti il rischio, ineffabilmente, a volte, potrebbe essere quello di ripercorrere gli stessi errori.
Il percorso che ha portato la transizione dagli orfanotrofi alle comunità è durato circa un decennio, solo nel corso degli anni ’80, infatti, sono stati avviati gli interventi di natura politica per il superamento dell’istituzionalizzazione; occorre aspettare il 2001 per arrivare alla Legge n.149 del 28 marzo, che fissa e ne stabilisce la chiusura nel “relativamente” vicino 2006, e assistere alla loro sostituzione con le Comunità alloggio per minori.
Se colleghiamo per un attimo le date di questa evoluzione normativa e di servizio, non possiamo non fare cenno al cambiamento della percezione dei diritti dei minori. Le Nazioni Unite, infatti, sanciscono questo cambiamento con l’adozione della Convenzione ONU sui diritti dell’infanzia e dell’adolescenza, adottata dell’Assemblea Generale il 20 novembre 1989.
L’Italia ratifica la Convenzione solo il 27 maggio del 1991, con la Legge n.176. Devono quindi passare 15 anni prima che dall’enunciazione sacrosanta di principi legati ai diritti, si arrivi alla modifica di un tassello di accoglienza compatibile con gli stessi.
La Regione Siciliana, in coerenza con i cambiamenti che hanno investito la Nazione a ridosso degli anni ’80, si dota infatti della Legge Regionale 22/86, una legge che nonostante le diverse modifiche e integrazioni intervenute nel corso degli anni, regolamenta a tutt’oggi, e definisce gli standard strutturali e organizzativi di tutti i servizi socioassistenziali.
Fatto il quadro, adesso, occorre un’opportuna riflessione sulla condizione attuale delle comunità, sul loro ruolo rispetto alla dimensione attuale della genitorialità, al loro collegamento con i servizi sociali, alla generazione di bambini e adolescenti che si trovano a gestire nel lungo e delicato momento attuale, e al delicatissimo ruolo del tribunale dei minori e della procura dei minori, in cui entra a gamba tesa la riforma Cartabia, tesa a far sparire questi due spazi importantissimi.
Nel corso delle mie esperienze, Istituzionali e non, mi sono spesso imbattuta in famiglie, che, alla ricerca di aiuto, perché in condizioni di fragilità economica, avevano paura di rivolgersi ai servizi sociali, perché angosciate dall’idea che potessero toglier loro i bambini per inserirli in comunità. Qualcuno potrà sorridere di questa cosa, ma io vi assicuro che è ancora opinione diffusa in molte realtà; per queste ragioni va ricordato che le motivazioni che portano a provvedimenti cosi importanti sono legate all’abbandono, al maltrattamento, all’abuso, e purtroppo a tutte le altre motivazioni di pari gravità, certamente non alla povertà presente in una famiglia accudente e presente, innanzi alla quale il servizio sociale ha il ruolo di protezione, aiuto e ricerca di sostegni.
Le comunità alloggio per minori svolgono un ruolo fondamentale nell’accoglienza e nell’educazione dei bambini e degli adolescenti che non possono vivere con le loro famiglie, la loro funzione è quella di integrare o sostituire temporaneamente le funzioni familiari compromesse e offrire un ambiente educativo relazionale in cui i minori possano elaborare un progetto futuro. Nonostante gli sforzi di molte comunità di qualità e il lavoro prezioso di molti assistenti sociali, questo sistema però è entrato in sofferenza.
Concentriamoci su Palermo
Certamente questa sofferenza è legata sia ad aspetti organizzativi ed economici, motivo per cui in questo momento, a livello Regionale, si stanno rivedendo alcuni aspetti relativi agli standard, ma anche perché nel tempo si è perso di vista l’obiettivo principale. Quello di considerarle come snodo educativo per costruire un progetto di vita individuale attorno al minore in sinergia con il servizio sociale; costruendo tasselli di opportunità per la fuoriuscita dalle comunità nel minor e breve tempo possibile, utilizzando al massimo gli strumenti dell’affido familiare, dell’adozione e nei casi più difficili dell’opportunità di rendere autonomo il percorso al 18esimo anno, realizzando inclusione lavorativa e autonomia abitativa.
Questo lavoro è stato reso complicatissimo da una multifattorialità di eventi: anni bui di ritardi nei pagamenti, superati (si spera per sempre!) due anni e mezzo fa (almeno per quanto riguarda il Comune di Palermo); e dal numero sempre insufficiente di assistenti sociali (anche questo superato grazie a una attività di potenziamento considerevole in due anni e mezzo).
Insieme a questo, il lavoro per rimettere al centro il progetto educativo, ha visto tre assi di potenziamento in un disegno unico:
- l’avvio di Pippi, un LEA, importantissimo per restituire strumenti alla genitorialità;
- il potenziamento con un investimento di oltre 700mila euro dello strumento dell’affido familiare, riattualizzandone la funzione attraverso l’utilizzo del privato sociale e dell’equipe multidisciplinari;
- una gara importantissima (di oltre 13mln) il cui disegno è venuto fuori grazie al prezioso lavoro del coordinamento dei servizi sociali e di tutto il servizio sociale, attraverso la quale si introduce un nuovo modello di relazione con le comunità per la costruzione del progetto di vita individuale del minore e della sua “dote educativa” e del (quando possibile) recupero della rete familiare.
Questo lavoro è venuto fuori dopo l’analisi di una fotografia sulla qualità del ruolo delle comunità e dopo una verifica anagrafica dei tempi di permanenza nelle stesse. Resta necessario, in altre sedi, alleggerire i percorsi di adozione.
Come ho sempre detto, i processi di cambiamento che riguardano il sociale, sono processi lenti, di cui i frutti non sono immediati, ma certamente questi cambiamenti produrranno i loro effetti, purtroppo, però queste spinte non potranno esprimersi al meglio se in questo lavoro di rivisitazione degli standard, riguardanti le comunità, la Regione non eserciterà un cambio di #RottaSoci@le, con alcuni cambiamenti netti:
- realizzare un filone specifico di comunità che riguarda l’accoglienza dei minori vittime di dipendenza, che oggi finiscono nelle comunità alloggio, inserendosi in un delicato e fragile contesto di altri minori, senza equipe specifiche, creando un mix esplosivo, innanzi al quale gli educatori sono chiamati, senza adeguato supporto a lavorare costantemente in emergenza;
- stabilire standard qualitativi, organizzativi ed economici diversi, nel caso in cui le comunità siano chiamate ad accogliere minori con disabilità;
- stabilire una ricettività (maggiore di quella attuale) ordinando il sistema di deroga all’ospitalità con paletti chiari e modalità armonizzate con il TM e la Procura Minori;
- determinare standard specifici legati alla fascia 0-6 per accelerare l’affido e l’adozione;
- collegare il prezioso strumento della mediazione riparativa ai minori che hanno commesso reato e ospitati in comunità;
- aprire un tavolo nazionale che metta ordine sul ruolo della famiglia di origine.
Questi cenni vogliono solo essere uno spunto per contribuire operativamente ad una riflessione legata agli attori di sistema sul complesso e delicato momento che riguarda lo spaccato infanzia/adolescenza, in considerazione che quei minori oggi in comunità sono già i cittadini della Palermo di domani, senza dimenticare che l’educazione alla genitorialità resta il tassello fondamentale sul quale costruire servizi diversi, più stringenti e più attuali, perché i bambini “hanno bisogno di modelli, piuttosto che di critiche”.
Conservando nel cuore un bellissimo pensiero di Madre Teresa di Calcutta: “I figli sono come gli aquiloni: gli insegnerai a volare, ma non voleranno il tuo volo. Gli insegnerai a sognare, ma non sogneranno il tuo sogno. Gli insegnerai a vivere, ma non vivranno la tua vita. Ma in ogni volo, in ogni sogno e in ogni vita rimarrà per sempre l’impronta di quell’insegnamento”.