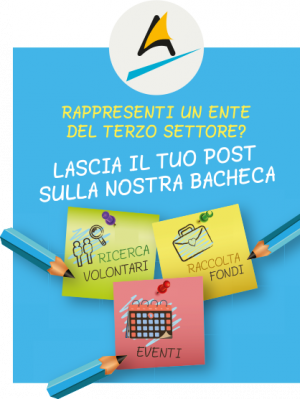PALERMO. 300 persone detenute su 450 sono impegnate a vario livello, a scuola, in corsi professionali e lavori interni al carcere. Il grande problema resta ancora incrementare sempre di più i progetti di reinserimento sociale e le possibilità abitative per coloro che, una volta liberi, non hanno una famiglia e una casa dove vivere. A raccontarlo, con quasi trent’anni di esperienza sul campo e, da tre anni alla guida di una delle case di reclusione più antiche d’Italia, è Fabio Prestopino, direttore della Casa di reclusione “Calogero Di Bona”, noto come carcere Ucciardone di Palermo.
In questo momento non è un carcere sovraffollato.
Quello che è importante non sono tanto i numeri quanto le condizioni di vivibilità. Abbiamo persone con pene definitive piuttosto lunghe o che non sono in attesa di primo giudizio. Questa è una Casa di reclusione composta da diversi edifici antichi, per lo più ristrutturati, pienamente immersi nel verde con alberi centenari.
Quante persone di origine straniera ci sono?
Rispetto alla media nazionale del 30 e 35%, le presenze sono intorno al 10 e 12%. Come sappiamo, c’è una maggiore concentrazione di persone straniere nel Centro Nord del Paese.
Tra le 450 presenze ci sono persone con fragilità?
Sì, purtroppo, ce ne sono parecchie. Teniamo presente che, spesso, il carcere è il destinatario finale di molti problemi sociali. Tra i più grandi problemi c’è quello delle droghe sempre più diffuse e ormai accessibili anche ai meno abbienti. Tutto ciò come conseguenza porta a grossi problemi di salute mentale. In collaborazione con l’azienda sanitaria provinciale, cerchiamo di aiutare queste persone, pensando pure al momento in cui usciranno dal carcere.
Purtroppo, alcune persone detenute, non appena finiscono la pena, non hanno punti di riferimento.
La mancanza di legami familiari, affettivi o amicali è un problema molto serio perché ancora i servizi territoriali non riescono ad intervenire tempestivamente per tutti. In alcuni casi di persone (italiane e straniere) che erano completamente sole e senza risorse, siamo riusciti, prima che ritornassero libere, a trovare delle sistemazioni, grazie ad un lavoro di rete con altre realtà. Il rischio maggiore di chi uscendo dal carcere non ha nessuno è proprio quello della recidiva. A volte abbiamo stranieri che non hanno alcun tipo di documento. In aiuto di chi è solo c’è un progetto, portato avanti dall’ufficio del garante regionale delle persone detenute. Questo, però, non riesce a rispondere alle persone che hanno problemi di salute fisica o mentale.
Quali attività possono essere svolte dalle persone recluse?
Dentro la Casa di reclusione ci sono molteplici attività. Naturalmente, alla base di tutto, la principale offerta è quella dell’istruzione. Partiamo dall’alfabetizzazione per poi proseguire con la scuola media e la superiore alberghiera; da due anni abbiamo anche quella universitaria. Ad oggi, abbiamo 7 persone detenute iscritte a corsi universitari (agraria, filosofia, ingegneria) accompagnate negli studi da tutor. La percentuale più alta di frequenza si divide tra la scuola media e la scuola superiore alberghiera. Complessivamente, nei tre gradi scolastici, abbiamo circa 150 persone iscritte.
Per quanto riguarda invece i corsi professionali?
Abbiamo il corso per Peer Supporter, a cui tengo molto, cioè per assistenti alla persona. Si tratta di persone detenute che si dedicano ad accogliere chi, per la prima volta, entra in questo istituto, evitando che, questo primo impatto, possa essere traumatico. Poi, abbiamo una decina di corsi professionali. Fra questi ci sono quelli nel settore dell’edilizia, orticultura, elettrico, sartoria e cucina. Inoltre, abbiamo il pastificio che, affidato ad una rete di associazioni, presto, riprenderà l’attività. Sono consapevole che il mercato del lavoro richiede anche altre professionalità che non abbiamo. Per esempio, mancano i tornitori ma i macchinari per formare queste figure non possono essere installate in carcere. 300 sono le persone impegnate nelle varie attività del carcere compresi i lavori quotidiani di pulizia e cucina. A questi si aggiunge chi fa tirocini formativi all’esterno presso alcune aziende.
L’obiettivo alto resta comunque il reinserimento sociale?
La sfida rispetto all’abbattimento della recidiva è quella di formare e fare acquisire competenze che favoriscano l’occupazione lavorativa. Per questo, cerchiamo di impegnarci in vario modo in una prospettiva di breve e medio termine. Si lavora sulla consapevolezza della persona sul piano delle proprie capacità che possono essere rafforzate dagli studi, dai corsi o dalle iniziative culturali. L’intento è quello di offrire alcune possibilità per l’inserimento nel mondo del lavoro. Le criticità che esistono sono ancora tante nella nostra società. Chiaramente, in una popolazione carceraria in cui le persone fragili sono sempre di più, ci sono difficoltà maggiori anche sul piano del reinserimento sociale.
Quanti educatori ovvero funzionari giuridico pedagogici sono presenti?
Per la prima volta posso dire che questo tipo di personale è numericamente sufficiente rispetto al numero dei detenuti. Abbiamo un team di 11 donne; si tratta di persone competenti che hanno anche una sorta di ‘vocazione’ a svolgere il ruolo educativo in carcere. Chiaramente, queste figure devono essere. Necessariamente, coadiuvate anche da una rete di altri esperti tra psicologi, criminologi mediatori culturali e operatori sanitari; a questi possiamo aggiungere pure i volontari e altre figure esterne.
Quali associazioni sono presenti e che cosa fanno?
In realtà come associazioni di volontariato ‘pure’ ne abbiamo solo due: Asvope e Crivop. Dopo il Covid si è ridotto il numero dei volontari. Questi svolgono più che altro attività di intrattenimento con un’attenzione maggiore alle persone detenute più fragili e problematiche. Tra le iniziative, l’Asvope si sta dedicando alle attività manuali come il disegno. Il Crivop sta per attivare uno sportello di ascolto per un’assistenza più diretta alle persone detenute.
Quanto è importante il lavoro di rete?
Per una efficace opera di trattamento rieducativo l’unica strada è quella di lavorare in rete tra istituzioni, associazioni, imprenditori (che in Sicilia sono pochi), personale penitenziario (polizia e educatori), medici, psicologi e assistenti sociali. Si è riattivato il Consiglio di Aiuto Sociale che è un organo che aiuta le persone detenute e le loro famiglie con il compito importante di accompagnare anche chi non ha famiglia o ha problemi di salute.
Che carenze possiamo evidenziare in questo periodo?
Quella più rilevante è che siamo tutti quanti immersi in una burocrazia lentissima che ci paralizza. Per esempio, abbiamo una sezione, per circa 60 persone, che aspetta ormai da quasi tre anni di essere ristrutturata. E’ l’unica sezione in cui purtroppo non ci sono le docce in camera.
Che cosa bisogna fare per sciogliere tutti gli stereotipi sulla persona detenuta?
Il modo migliore per abbattere il pregiudizio nei confronti delle persone detenute è quello di conoscere questo mondo. E’ significativo che, negli ultimi anni le realtà penitenziarie si siano aperte all’esterno. Ricordiamoci sempre che non abbiamo uno zoo dove ci sono animali in gabbia ma un luogo in cui ci sono persone che stanno scontando una pena cercando di trovare una redenzione morale e soprattutto sociale. A tal fine abbiamo una serie di iniziative di sensibilizzazione sociale e culturale che coinvolgono scuole, università e altre realtà.
Anche per i casi più difficili bisogna non perdere mai la speranza?
Certamente. Ricordo, in particolare, una persona che, per due anni, è stata intrattabile e refrattaria ad ogni regola. Non solo per merito mio ma, anche, dopo un nostro colloquio, a poco a poco, è riuscita a cambiare in meglio. Ha iniziato a fare teatro, poi alcune attività lavorative e, perfino, oggi l’università. Questo ci conforta e ci spinge ad andare sempre avanti anche se sappiamo che non è sempre così.