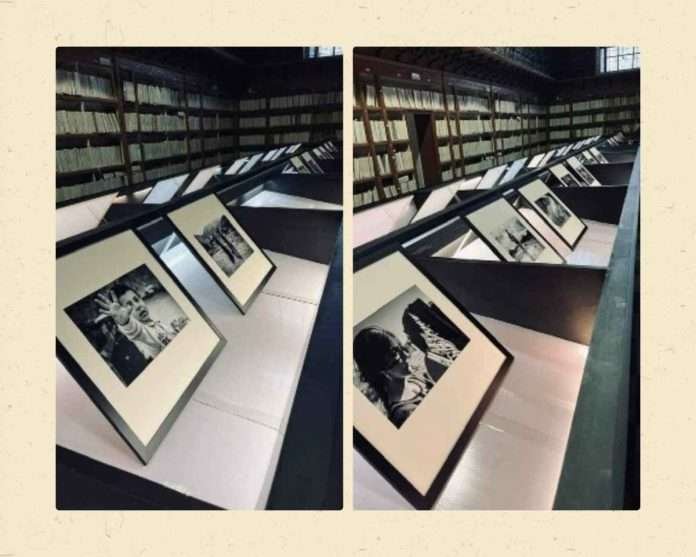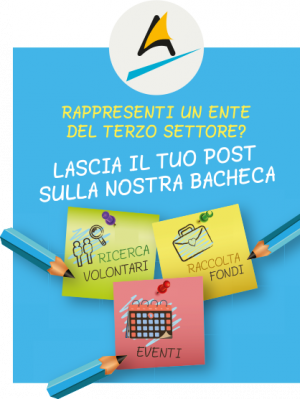PALERMO. “Fiori di Campo: perché era maggio e quei bambini erano come fiori”. Così si è intitolata la mostra fotografica di Marina Galici, a cura di Colletivof, che ha emozionato i suoi visitatori dall’11 al 23 aprile. Allestita presso l’Archivio storico comunale di Palermo, è stata narrazione della vita nel campo rom di Palermo sgomberato definitivamente dalla Favorita nel 2019.
A farne racconto per noi Marina Galici con la delicatezza di chi guarda il mondo attraverso l’obiettivo di una macchina fotografica
Era l’anno 2011, quando entrai per la prima volta in un campo rom. Io, una gagì, una comune e banale gagì. Entrai per invito casuale di una donna rom, anche se io non credo in verità alla pura casualità. Credo piuttosto che l’attrazione verso questo popolo da sempre manifesta in me, questa curiosità e voglia di conoscenza, abbia nel tempo preso forma divenendo realtà, un’opportunità.
Entrai per invito quindi d’una donna rom, che io amo definire una donna da gran sorriso, Mirveta, che quasi quotidianamente incontravo dinanzi ad un grande magazzino commerciale in via Alcide De Gasperi, intenta a fare la questua con le sue figliole dai grandi occhi neri e dallo sguardo profondo, Alessandra e Sergiana.
Fui invitata come ospite spettatrice della loro grande festa annuale, l’Ederlezi, o diversamente chiamata, Festa della primavera. La festività delle Ederlezi cade ogni 6 maggio ed è una festa che coinvolge quasi tutte le comunità Romanes del mondo, che attraverso dei riti tra il sacro e profano e riti propiziatori ha come intento ultimo la purificazione dell’anima e quindi la rinascita.
Io dico sempre che fummo in tre ad accedere, tre sprovveduti: io, il mio terzocchio e la macchina fotografica; ignari di quanta Primavera, di quanti fiori di campo, di quanto respiro avremmo incontrato in quel giorno.

Così, varcato quel confine immaginario, quel solco profondo di pregiudizi, magistralmente scavato dalla mia società civile, mi ritrovai dinanzi a uno scenario imprevedibile.
Uno scenario variegato dai colori vividissimi…: folte macchie di margherite gialle intervallate da distese desolate, catapecchie adornate a festa con collane di fiori e foglie verdi da dove si sentiva riecheggiare canti dalle note antiche ed ignote, ventri di donne ondeggianti in danza chiusa a cerchio, scoppiettanti falò e agnelli pronti al sacrificio. E poi…, sciami di bambine e bambine che sbucavano da ogni dove, a gara davanti all’obiettivo per immortalare un sorriso, una smorfia, uno sguardo provocante.
Ed io …, adrenalina a 1000, mai generata tanta a battito ciliare. Questo battito cardiaco accelerato durò per altri giorni ancora ed io mi chiedevo – quando si quieterà?
Girovagavo per quel campo senza alcuna direzione, come trasportata, sospinta, priva di parole. Solo click! E tutto era lì, davanti alla mia lente che ingigantiva l’occhio incredulo, in quel lager a cielo aperto. Mi trovavo, e non capivo allora, dentro una grande scuola senza tomi e banchi, solo fatiscenti baracche dove poi avrei capito che maestri si sarebbero rivelati i bambini, dottori gli anziani.
Da quel giorno cominciai saltuariamente a frequentare il Campo per un vago e indistinto – non so ché -che continuava ad attrarmi verso loro, affascinandomi. E fu proprio questo sfocato e sfuggente – non so ché – che via via si comandò regista di una sceneggiatura perfetta dentro di me, incontro su incontro, sino a divenire a mia insaputa un cammino maestro.
Imparai, sì imparai… Imparai molto da loro e questo è un ringraziamento vivo. Imparai proprio dentro quelle Kampine nei momenti di lungo silenzio nelle ore torride d’estate oppure gelando le ossa nelle rigide giornate d’inverno ostile, mentre seduti sui cuscini a piedi scalzi, le donne e bambini riuniti parlavano tra loro musicando alle mie orecchie una lingua sconosciuta. Imparerai il mestiere di madre, malgrado io già lo fossi. Sembra strano a dire considerando il pregiudizio diffuso sull’abuso che le mamme rom fanno ai sui loro bimbi costringendoli alla strada.
Imparerai qualcosa di diverso, imparai che al di là della cura corporale e della tutela, vi era un amore altro che non negava, anzi alimentava, l’aria del loro viaggio, il senso del gioco della vita.
Imparai anche la resistenza composta e dignitosa ai giudizi a sassate dell’anonimo passante per strada. Imparai a difendere oltre agli eventi l’integrità di fede e d’orgoglio per il proprio popolo.
E poi, imparai qualcos’altro rispetto al mio senso di proprietà, quella proprietà come intesa dal mio fuori, li la proprietà era un bene sì, ma un bene dell’anima spoglia, ovvero tutto ed ogni cosa era importante ma nulla era essenziale; i beni raccolti da ognuno erano beni per la comunità, da mettere in circolo, da condividere al momento del bisogno, secondo una logica naturale, ma strutturata di mutuo soccorso, di economia orizzontale.
Imparai quindi che non esiste individualità senza solidarietà e che libertà è avere un nome e che dignità è l’essere riconosciuto.
Dentro il campo o fuori dal campo gli esseri umani -tutti- diversamente eguali: la stessa pelle che si drena d’acque, lo stesso stomaco affamato, gli stessi polmoni che si espandono di vita.
Per ognuno la medesima urgenza: l’uomo necessità dell’uomo.
Con l’altro, nell’altro, dell’altro si definisce. Io, per uno strano volere della coscienza, fui scelta dal caso a definirmi anche attraverso loro.
Il processo verso l’interculturalità ebbe un progredire lento, per gradi, ma ogni stadio raggiunto non ritornava più indietro, ed era una terra conquistata, un filo spinato oltrepassato. Ero convinta che tutte quelle acquisizioni ideologiche e politiche che mi sembravano comprovate, che mi sembrava che mi appartenessero solide già da tempo, non avrebbero preso gioco su di me. Ma ho dovuto amaramente ricredermi, distinguendo quello che era il pensiero concettuale e quello che poi nasceva dall’esperienza diretta.
In verità, tutto il contaminato della mia classe sociale medio borghese d’origine venne lo stesso a galla, come un residuo no biodegradabile. Soprattutto si espresse nei miei sensi di colpa come spettatrice rea, quella fotografa che carpisce dall’opposta sponda.
E vennero fuori proprio dal contatto frontale, del conflitto emotivo, l’empatizzare la ferita del rifiuto e della vessazione inferta nei secoli, della violenza psicologica della ghettizzazione, di quell’ abuso politico e culturale senza alcun movente o attenuanti.
Tutto ciò fu rivoluzione dentro di me, una rilettura attenta dei miei credi, della mia educazione culturale e delle loro crepe.
Ogni passaggio assunto conduceva al successivo, dall’ emotivo all’umano, dall’umano al sociale, dal sociale al civile, dal civile al politico.
E questa cerimonia a questo rito di iniziazione, stranamente e magicamente, lo tenne e lo condusse da sola la mia macchina fotografica obsoleta: immortalava l’emozionale, sviluppava il politico.
Poi avvenne, avvenne quell’Aprile del 2019, l’imprevedibile prevedibile: lo sgombero.
Qualcuno lo chiamò, attenuando, dismissione del campo. In effetti, nessuno di loro fu buttato in mezzo ad una strada, per ogni famiglia fu prevista una locazione a carico del Comune per quanto provvisoria, fu garantito un tetto. A differenza dei vari sgomberi avvenuti in tutta Italia.
Ma per loro, rimase uno sgombero, una violenza sulla loro comunità: uscirono per sempre dal campo uomini, donne, bambini con poche valigie appresso. Lì, famiglia per famiglia, in poche ore raccolse l’essenziale di circa vent’anni; la loro storia in quel lembo di terra lo lasciò alla furia boia delle ruspe e di un’altra volontà superiore. L’ennesima.
Uscirono fratelli, sorelle e tanti figli allo sbaraglio della grande incognita: la sopravvivenza all’umano, in tutte le sue in tutte le sue contraddizioni, in tutte le sue declinazioni.
Fu -era- è stato il campo rom “la Favorita”, che non ebbe particolari favoritismi, ma li seppe fare.
Ne resta, in fin dei conti, testimonianza imperitura le mie fotografie, come documento politico, come documento d’ una verità che dell’impossibile si rese possibile nella razza umana.
A dire il resto le foto, che hanno aperto a tutti il campo rom lasciando intravedere quel sole di maggio sui figli del Campo, che sono Fiori.