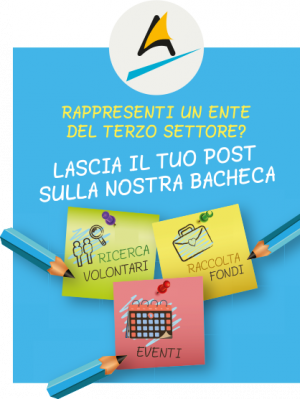PALERMO. Da qualche anno tra gli aggettivi che la qualificano, ce n’è anche uno che è messo lì accanto per dire un in più, per raccontare un aspetto dell’Università che probabilmente non è noto a tutti. L’aggettivo è umile. Il nome che qualifica è quello di Accademia. Ne ha parlato Clelia Bartoli, docente per Giurisprudenza del corso in Deontologia, sociologia e critica del diritto, a margine della Giornata della didattica Innovativa che si è svolto nelle scorse settimane a Palazzo Steri. Lo ha fatto, partendo proprio da una delle esperienze vissute con i suoi studenti negli anni accademici del 2017/18 e del 2018/19.
Un centinaio di studenti di giurisprudenza, in quell’occasione, dopo una serie di incontri, sono andati fuori dalle aule del plesso Bernando Albanese, per strada: lì hanno condotto indagini per conoscere l’Albergheria e per conoscere chi l’Albergheria la abita e ce l’ha cara come luogo di lavoro. Dopo le indagini condotte, dopo incontri e interviste, nell’anno accademico successivo, sono stati cinquanta gli studenti che hanno collaborato alla stesura della bozza delle Linee guide per la regolarizzazione dell’area del Mercato dell’Usato e del Libero scambio dell’Albergheria. Così hanno fatto lezioni, “muovendosi – dice la Bartoli- nelle vie del mercato, frequentando gli uffici del Comune e i giardinetti della parrocchia dove si tenevano le assemblee dei venditori, in piazza Colajanni durante i cerchi di discussione per attuare una democrazia veramente partecipativa organizzati insieme alla nascente associazione degli operatori del mercato, alla Prima Circoscrizione e ad S.O.S. Ballarò”.
Gli studenti sono i protagonisti delle lezioni ma non solo loro. “Gli studenti – continua la docente – partendo da alcune mie sollecitazioni, si fanno comunità di apprendimento e di ricerca, dove il sapere circola – non c’è come unica fonte il docente. Questa comunità, così, costruisce nuovi saperi e nuove pratiche. Oltre i giovani sono presenti esperti esterni e questo proprio per abbattere i muri che separano l’accademia dalla società. Gli uni e gli altri sono soggetti pensanti e creativi e insieme diventano una forza. Non solo hanno voce in capitolo perché sono testimoni di una cosa che hanno vissuto ma perché hanno risorse intellettuali e creative che messe in un determinato contesto possono fiorire”.
E gli esperti non sono stati solo i mercatari dell’Albergheria ma ad alcuni corsi i ragazzi che hanno avuto processi penali o migranti del Cpia o ragazzi con esperienza di tossicodipendenza. Tutto perché “sono persone che hanno un sapere preziosissimo ma che per status sociale non gli viene riconosciuto, persone che normalmente sono dei marginali”.
In “Accademia alla rovescia, lezioni di diritto per dirottare il verso del sapere”, la Bartoli spiega ancora più approfonditamente la sua scelta metodologica. “Bisogna guardare al diritto dall’esterno, dalla prospettiva di chi sta al margine della società e si trova in una condizione di extra-legalità, portando alla luce aspetti del fenomeno giuridico che sarebbe stato difficile o impossibile cogliere restando nella posizione del giurista, dello studente universitario standard, o di quella parte di cittadinanza cui il legislatore pensa quando redige le norme”.
E nell’esperienza con i mercatari dell’Albergheria, come in altre, “è stato particolarmente istruttivo mettersi nel ruolo di un legislatore così tanto prossimo alle persone cui le regole sarebbero state indirizzate. In questo modo gli studenti hanno fatto direttamente esperienza del processo di codificazione di norme consuetudinarie, si sono confrontati con delle dispute di attribuzioni e competenze tra organi diversi dello Stato, hanno sondato la capacità del diritto di regolare il conflitto sociale e la difficoltà estrema di armonizzare o quantomeno bilanciare istanze divergenti, avvertendo la necessità di affinare una creatività giuridica e istituzionale per trovare soluzioni che tenessero conto di coloro che di norma restano esclusi. Hanno saggiato potenzialità e limiti del diritto. E così molti dei temi studiati durante i loro anni a Giurisprudenza hanno preso finalmente corpo”.
I corsi del plesso, che prima era il cinema Edison, si concludono con un colloquio. “Tutto il percorso è un esame. La valutazione non è il numero ma è un quadro e ne viene, visto che non è un voto che li imprigiona, molto spesso gli aspetti su cui lavorare, le criticità sono quelle che li appassionano di più perché possono crescere”.
Questa è l’Università “Umile” perché così l’università “si mette ad imparare: va dalle persone marginali a chiedere il loro sapere; guarda i suoi studenti e gli lascia spazio, quasi a cedergli il mestiere dei suoi docenti”. C’è anche un altro aggettivo per raccontare un’ altra Università. L’aggettivo è umile. Il nome che qualifica è quello di Accademia. Accedemia Umile.