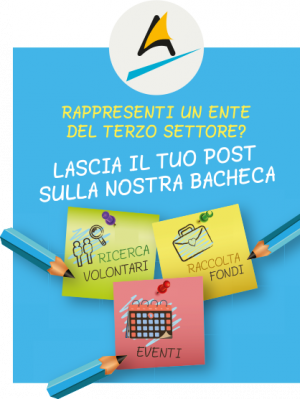PALERMO. A 30 anni dalle Stragi di Capaci e via D’Amelio, la ricerca della verità su quei delitti va avanti ancora oggi. Ci sono state inchieste e processi ma sono tante ancora le domande che attendono risposta. Tra gli interrogativi più importanti c’è il progetto della strage di via d’Amelio e l’accelerazione che ha portato all’uccisione di Paolo Borsellino dopo 57 giorni dal giudice Falcone.
“L’Italia è incapace di affrontare la verità”, dichiara Roberto Scarpinato. Perchè è così difficile cercarla? A rispondere è l’ex procuratore generale di Palermo, nel corso di un evento dedicato all’antimafia organizzato dalla redazione di ANTIMAFIADuemila, a Villa Filippina, in occasione dei 30 anni dalle Stragi.
A distanza di una settimana dal sesto processo sulle Stragi, a 30 anni dalla strage di Via D’Amelio, c’è un interrogativo che dobbiamo porci con più forza su tutti gli altri, dichiara l’ex procuratore: “Riusciremo mai ad avere una completa verità giudiziaria sulla strage di via D’Amelio? Una verità che vada oltre il livello degli esecutori materiali e dia un volto ai mandanti e ai complici esterni? Se dobbiamo essere realistici, alla luce degli ultimi eventi, la mia risposta è no. Per ragioni di sistema. Per ragioni che attengono al potere in Italia”.

Quel potere che non ha mai consentito la processabilità e la condanna dei mandanti, dei complici esterni di tutte le stragi che hanno segnato la storia della prima Repubblica.
“Una storia tenuta a battesimo da una strage politico mafiosa, quella del primo maggio 1947 di Portella della Ginestra, conclusasi nel bagno di sangue delle stragi politico mafiose del 1992 e 1993. Tra queste una sequenza ininterrotta di attentati che non eguali in nessuna storia europea – continua l’ex procuratore. Una storia di stragi e di eterna sconfitta della giurisdizione che non è mai riuscita ad andare oltre il livello degli esecutori materiali. In alcuni casi ha fallito pure questo compito elementare come accaduto per la strage di piazza Fontana, a Milano, del 12 dicembre 1969: 17 morti e 88 feriti senza giustizia. Nessun colpevole“.
I DEPISTAGGI NELLA STORIA ITALIANA. UN CICLO SENZA FINE
La considerazione di Scarpinato è che a volte “indagini che riguardano le stragi italiane sono state sistematicamente sabotate e depistate da esponenti degli apparati statali”. “Circostanza che non mi stanco di ripetere: è accertata da una serie di condanne definitive dei vertici dei servizi segreti della Polizia condannati per depistaggio. Ricordiamo che per la strage di Milano della Banca dell’Agricoltura del 1969 sono stati condannati con sentenza definitiva per avere depistato le indagini, due vertici dei servizi segreti, il generale Maletti e il capitano La Bruna”, spiega Scarpinato.
Per la strage di Peteano del 31 maggio 1972 sono stati condannati con sentenza definitiva del 1992 per depistaggio, il generale Dino Minganelli e il colonnello Antonino Chirico. Per la strage di Brescia del 28 maggio del 1974 “è stato accertato che i servizi segreti avevano nascosto alla magistratura, per 40 anni, che uno dei soggetti condannati per la strage, Maurizio Tramonte, era stato un collaboratore dei servizi segreti”.
Per le indagini sulla strage di Bologna del 1980 sono stati condannati con sentenza definitiva per avere depistato le indagini, due vertici dei servizi segreti, il generale Musumeci, il colonnello dei Carabinieri Belmonte, l’agente segreto Pazienza.
Continua così l’ex procuratore: “Non è casuale che nelle indagini per le stragi del 1992 e del 1993 sia stato replicato tutto il vasto repertorio dei depistaggi che è stato sperimentato nelle indagini sulle stragi degli anni ’70 e ’80. Dalla sottrazione di documenti essenziali alla creazione di falsi collaboratori, all’eliminazione di soggetti che erano a conoscenza di segreti scottanti e stavano per iniziare a collaborare”.

TRA VERITÀ NASCOSTE E TECNICHE DI DEPISTAGGIO
Quanto alla sottrazione di documenti essenziali, la sottrazione dell’agenda rossa di Paolo Borsellino è solo il caso più clamoroso. Non dimentichiamo che dopo l’arresto di Salvatore Riina “fu consentito ai mafiosi di far sparire tutti i documenti che si trovavano in casa sua ingannando la Procura della Repubblica”, ha ricordato il magistrato -. “È stata manomessa l’agenda Cassio di Falcone, la sua agenda elettronica, con interventi successivi alla strage del 23 maggio che hanno cancellato, come è stato accertato nelle consulenze, dei file che si trovavano all’interno”.
“Si tratta di una replica. Di tecniche di depistaggio poste in essere per le stragi, della ‘strategia della tensione’. Nel processo per la strage di piazza della Loggia a Brescia è stato accertato che due ore dopo l’esplosione era stato impartito l’ordine di ripulire frettolosamente, con le autopompe, il luogo dell’esplosione spazzando via indizi, reperti e tracce di esplosivo prima che arrivassero magistrati e periti. Misteriosamente sparirono anche i reperti e le tracce di esplosivo prelevati in ospedale dai corpi dei feriti e dei cadaveri”, continua l’ex procuratore.
Anche per la strage di Bologna è stato accertato che le indagini sui mandanti esterni di quella strage, recentemente identificati in Licio Gelli e Umberto Federico D’Amato, capo dell’ufficio Affari riservati del Ministero dell’Interno, “sono state depistate per più di 50 anni dalla sottrazione alla Magistratura di un documento importante”, un manoscritto di Gelli dove Gelli aveva annotato movimenti bancari, che, dopo che essere stati ritrovati dai magistrati di Bologna hanno consentito un salto nelle indagini sui mandanti delle Stragi di Capaci e via D’Amelio.

A proposito di replica del sistema dei depistaggi sappiamo che per le stragi del ’92 e ’93 sono stati eliminati Antonino Gioè e Luigi Lardo poco prima che entrambi iniziassero a collaborare. Il 13 aprile 1981 nel super carcere di Novara fu assassinato Ermanno Buzzi, condannato in primo grado per la strage di Brescia poco prima che iniziasse a collaborare con i magistrati.
Per quanto riguarda la creazione di falsi collaboratori si parla di Scarantino per la strage di via D’Amelio. Per la strage di Milano del 1969 fu coltivata la pista anarchica costruita appositamente per depistare le indagini. Per la strage di Bologna fu creata la falsa pista tedesca e così via.
“Perché accenno a questi precedenti? Perché questa continuità di metodologia di depistaggio, che va dalle stragi degli anni ’70, agli anni ’80 e arriva al ‘92 e ‘93 è un segnale inequivocabile della continuità dell’azione depistante degli apparati statali che hanno attraversato questa stagione“, spiega l’ex procuratore.
Un altro segnale di straordinaria continuità dalle stragi è nell’aprile 2022 quando la Corte d’Assise di Bologna condanna all’ergastolo Paolo Bellini come ulteriore esecutore della strage di Bologna del 2 agosto 1980. Esponente della destra eversiva, Bellini, uomo collegato ai servizi segreti, a Stefano Delle Chiaie è lo stesso Paolo Bellini che durante il periodo delle stragi del 1991 e 1992 è continuamente presente in Sicilia in dialogo costante con gli esecutori delle stragi, che, come ha dichiarato Giovanni Brusca suggerisce ai mafiosi di “fare attentati contro i beni artistici nazionali”.
Bellini è uno dei tanti soggetti gravitanti della destra eversiva che affollano lo scenario delle stragi di Capaci e via D’Amelio e del 1993. Insieme a lui, Pietro Rampulla, l’artificiere della strage di Capaci, esponente anche lui della destra eversiva. Antonino Gioè, Santo Mazzei e Saro Cattafi.
GIOVANNI FALCONE E LA STRAGE DI BOLOGNA
Che rapporto c’è tra la strage di Bologna dove la strategia della tensione raggiunge il culmine e i delitti di mafia? “Questo rapporto lo colse per primo Giovanni Falcone, il quale si rese conto che gli autori dell’omicidio Mattarella, Valerio Fioravanti e Gilberto Cavallini erano gli stessi autori della strage di Bologna del 1980. Si rese conto che la causale mafiosa dell’omicidio Mattarella era solo una causale apparente di copertura che occultava un’altra causale politica che doveva restare segreta.
Falcone definì l’omicidio Mattarella una replica del caso Moro. Lo disse esplicitamente nel suo intervento il 22 giugno 1980 alla Commissione parlamentare antimafia quando disse a proposito dell’omicidio Mattarella ‘è un’indagine estremamente complessa perché si tratta di capire se e in quale misura la pista nera sia alternativa rispetto a quella mafiosa oppure si compenetri con quella mafiosa. Il che potrebbe significare saldature e soprattutto la necessità di rifare la storia di certe vicende del nostro paese anche da tempi assai lontani’. È in questo contesto che Falcone fa riferimento alla strage di Bologna“, spiega l’ex procuratore Scarpinato.

Falcone è il primo che si rende conto del coinvolgimento della mafia nella strategia della tensione dall’origine del corpo borghese fino al progetto del colpo di stato del 1974, del 1979, alla strage del treno 904, alla strage di Pizzo Lungo. Ed è su questa pista che non smetterà mai di indagare come risulta dalla pubblicazione dei suoi diari nei quali la maggior parte è dedicata proprio agli ostacoli che il procuratore Giammanco gli pose per le indagini su Gladio e sui delitti politici.
“Sono stato testimone di uno scontro tra il procuratore generale Giammanco e Falcone a proposito delle indagini sui delitti politici, al punto che Falcone minacciò di dare le dimissioni dal pool antimafia proprio per gli ostacoli che incontrava. Falcone confidò ai suoi amici tra cui Paolo Borsellino che se fosse stato nominato procuratore nazionale antimafia avrebbe subito ripreso le indagini su quei delitti eccellenti anticipando a Borsellino che sarebbe pervenuto anche ad alcuni arresti”, continua Scarpinato.
I MOTIVI DI UNA VERITÀ INCOMPLETA
“Non si può pervenire ad una verità completa perché i segreti che si celano dietro quelle stragi, segreti che vengono da lontano e che portano lontano sono a conoscenza solo di un ristretto numero di capi mafia condannati all’ergastolo e sono ignorati da tutti gli altri uomini d’onore compresi numerosi esponenti della commissione provinciale di Cosa nostra”, spiega l’ex procuratore generale di Palermo.
Se si esaminano con attenzione tutte le risultanti processuali sulle stragi si può verificare che esiste un doppio livello informativo all’interno di Cosa nostra durante il periodo stragista. Il primo riguarda i componenti della commissione provinciale e gli esecutori materiali ai quali vengono comunicate solo le motivazioni delle stragi strettamente interne agli interessi esclusivi di Cosa nostra. Un secondo livello ristretto riservato solo a pochi capi e ai fedelissimi di Riina, i Graviano, Bagarella, Messina Denaro, i quali invece sono messi a conoscenza della partecipazione al piano stragista, di soggetti esterni, la cui presenza deve restare segreta anche all’interno dell’organizzazione mafiosa.
“Un primo momento rivelatore dell’esistenza di questo doppio livello informativo si evidenzia in occasione della riunione della commissione provinciale di Cosa nostra convocata da Riina nel dicembre del 1991 per comunicare l’inizio della stagione stragista. Sui contenuti e sulle modalità di svolgimento di questa riunione abbiamo le dichiarazioni convergenti di ben tre collaboratori di giustizia che facevano parte della commissione provinciale, Giovanni Brusca, Antonino Giuffrè, Salvatore Cangemi.
Tutti concordano che la riunione durò meno di 3 quarti d’ora e Riina si limitò a comunicare brevemente ai partecipanti che si sarebbe dato inizio a omicidi e stragi per vendicarsi di nemici come Falcone e dei traditori come politici che non avevano mantenuto fede agli impegni presi con la mafia“, continua Scarpinato.
I SEGRETI DI TOTÒ RIINA
Riina non dice una sola parola in quella riunione, infatti Brusca, Cangemi e Giuffrè non sanno che quella riunione del dicembre 1991 era stata preceduta da varie riunioni nelle campagne di Enna nel corso del quale Riina e un ristretto numero di capi, Benedetto Santapaola, Giuseppe Madonia di Caltanissetta, Benedetto Provenzano avevano a lungo discusso e poi approvato l’adesione di Cosa nostra a un complesso “piano di destabilizzazione politica“.
Un piano messo a punto da soggetti esterni a Cosa Nostra, da attuarsi con stragi e omicidi, che dovevano dare una spallata al vecchio sistema politico che non offriva più protezioni, che dovevano aprire la via all’ingresso in campo di un nuovo soggetto politico che allora era in fase di formazione.
Riina non dice che in quella riunione ad Enna si era entrati anche in alcuni dettagli esecutivi. Lo stesso Riina aveva anticipato che tutte le stragi dovevano essere rivendicate con la sigla dalla falange armata. Un’operazione, una sigla che era stata coniata dai servizi segreti.

Non si tratta dell’unico segreto che Riina tiene per sé e i suoi fedelissimi. Non comunica a nessuno di avere incaricato Domenico Ganci di partecipare nell’ottobre e novembre del 1991 ad una riunione segreta svoltasi fuori dalla Sicilia alla quale erano stati presenti importanti esponenti delle Istituzioni, politici tra i quali alcuni ministri in carica e altri pezzi grossi nel corso del quale era stato discusso un piano di destabilizzazione politica dello Stato e di secessione violenta della Sicilia dall’Italia.
Domenico Ganci risulta affiliato alla massoneria su disposizione di Riina ed era stato da questi delegato in precedenza a mantenerne i rapporti. Della partecipazione di Ganci a questa riunione sappiamo solo dal collaboratore Antonino Galiano con il quale Ganci si era confidato. Nessun altro dei collaboratori di giustizia, né Cangemi, né Brusca, né Giuffrè, né Ferrante sanno niente di questa riunione.
Ancora Riina non spiega perché dopo avere deciso di uccidere Falcone a Roma inviando nella capitale un commando capitanato da Matteo Messina Denaro, a Roma dove sarebbe stato facilissimo uccidere Falcone, che in quel periodo camminava spesso senza scorta, aveva cambiato idea decidendo che invece Falcone dovesse essere ucciso a Palermo con attentato esplosivo eclatante di difficilissima esecuzione che presentava un elevato coefficiente di rischio d’insuccesso.
Decisione che Riina aveva assunto dopo che nella primavera del 1992 si era incontrato a Palermo con personaggi importanti. Come ha riferito il collaboratore Salvatore Cangemi per averlo saputo da Raffaele Ganci, padre di Domenico Ganci, aggiungendo che questi personaggi importanti avevano guidato testualmente “la manina” di Salvatore Riina. Chi erano costoro? Nè Brusca, nè Giuffrè, nè tanti altri collaboratori sanno nulla di costoro.
Ancora a proposito del doppio livello informativo secondo quanto riferito dal collaboratore di giustizia Gioacchino La Barbera, che partecipò a tutte le fasi esecutive della strage di Capaci, ai sopralluoghi della preparazione della strage di Capaci presenziò anche un soggetto esterno che fino ad oggi non è stato mai individuato. Chi era costui? Nessun collaboratore ne ha mai parlato. Gaspare Spatuzza ha rivelato che pure all’operazione di caricamento di esplosivo della Fiat 126 fatta esplodere in via D’Amelio era presente un soggetto esterno a Cosa nostra. Chi era costui? Nessuno lo sa.
LA POLIZIA “CORROTTA” NELLA STRAGE DI VIA D’AMELIO
Chi erano gli infiltrati della polizia nella strage di via D’Amelio alla quale fece riferimento il 14 dicembre 1993 Franca Castellese quando, intercettata quando parlava col marito, il collaboratore Mario Santo Di Matteo, dopo che il loro figlio Giuseppe era stato rapito, lo scongiurò di non parlare ai magistrati di infiltrati della polizia nella strage di via D’Amelio? Erano forse gli uomini dei servizi che piombarono sulla scena dell’esplosione di via D’Amelio prima ancora della polizia e si impadronirono dell’agenda rossa?

Com’è possibile che a distanza di 30 anni non sia stato possibile conoscere l’identità di questi uomini dei servizi che furono riconosciuti come tali da ben due testimoni che hanno testimoniato nel processo Borsellino Quater, il vice sovrintendente Giuseppe Garofalo, in servizio alla stazione volanti, e Francesco Polo Maggi, sovrintendente della Polizia di Stato, in servizio nella squadra mobile di Palermo?
“A cosa si deve questo incredibile silenzio omertoso di Stato, sull’entità di questi uomini dei servizi che certamente operarono per primi sulla strage di via D’Amelio? Da chi furono avvertiti con tale tempestività da battere sul tempo le forze di polizia sull’esplosione di via D’Amelio? Erano in servizio a Palermo? O venivano in missione da Roma? Se venivano da Roma, da chi e quanto tempo prima fu loro indicato di recarsi a Palermo? E con quale ordine di servizio? Sono passati 30 anni e non siamo in grado di dare risposta a questo quesito elementare”, chiede l’ex procuratore generale di Palermo.
LA BARBERA E IL DEPISTAGGIO
Ancora a proposito degli infiltrati della polizia nella strage di via D’Amelio: Come faceva Arnaldo La Barbera, come scritto nella motivazione della sentenza del Borsellino Quater, a sapere nello stesso pomeriggio del 19 luglio che era stata utilizzata come autobomba una Fiat 126 facendo filtrare le notizie sull’agenzia di stampa tenuto conto che il blocco motore della Fiat 126 fu ritrovato soltanto il giorno dopo, il 20 luglio?
Come faceva La Barbera, com’è scritto nella motivazione della sentenza del Borsellino Quater, a sapere che le targhe applicate alla Fiat 126 erano state rubate nell’officina di Vincenzo Lo Fino tanto da inviare alle ore 11.00 del 20 luglio la polizia scientifica in quell’officina, tenuto conto che le targhe rubate furono rinvenute soltanto due giorni dopo, il 22 luglio, e che il blocco motore della Fiat 126 fu rinvenuto solo dopo alcune ore dopo le ore 11.00 del 20 luglio e cioè alle ore 13.00-13.30?
“Nella motivazione del Borsellino Quater tenuto conto di questi fatti i giudici ipotizzano che La Barbera aveva un infiltrato, che gli forniva notizie e se c’era un infiltrato perché costui non fornì le notizie prima che la strage venisse realizzata? O forse non era un infiltrato per impedire che la strage venisse effettuata ma piuttosto per seguirne le fasi operative e assicurarsi che andasse a buon fine?”, chiede Scarpinato.

I collaboratori Tullio Cannella e Antonio Calvaruso che curarono la latitanza di Leoluca Bagarella e che per questo motivo raccolsero direttamente da lui alcune confidenze hanno dichiarato che Bagarella riceveva input e indicazioni dall’esterno. Questa circostanza ha avuto una precisa conferma dal collaboratore di giustizia Giuseppe Ferro, che è stato condannato all’ergastolo per avere fornito la base logistica della quale si servirono gli autori della strage di via Georgofili di Firenze nella notte del 26-27 maggio 1993.
Ferro ha dichiarato in pubblico dibattimento che dopo la strage di Firenze Bagarella gli aveva chiesto un’altra base logistica a Bologna per una strage da eseguirsi in quella città e i dubbi sollevati da Ferro cercano l’opportunità e la convenienza di cosa nostra di eseguire un’altra strage che avrebbe causato morti tra la gente comune. Bagarella aveva risposto che lassù volevano che si facesse rumore.
2 GIUGNO 1993. ATTENTATO AL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO CIAMPI
“Chi erano quelli di lassù che volevano finalizzare le stragi a una finalità di eversione che trascendeva gli interessi immediati di cosa nostra? Chi furono coloro che il 2 giugno del 1993 collocarono un’autobomba in via dei Sabini lungo la strada che quel giorno doveva percorrere il presidente del consiglio Ciampi?
Nessuno dei collaboratori sa niente. Chi portò sul luogo dove esplose l’autovettura a Milano in via Palestro la sera del 27 luglio 1993 (finora le indagini non sono state in grado di dare risposta a questa domanda. Spatuzza non lo sa, Vittorio Tutino è stato assolto con formula piena dalla Cassazione. Chi era la donna bionda indicata da alcuni testimoni come persona vista all’interno di quell’autovettura a Milano mentre parlava gesticolando con un uomo poco prima che esplodesse?

Così risponde Scarpinato: “A ciascuna di queste domande potrebbero dare una risposta risolutiva coloro che conoscono tutte le risposte. I capi mafia stragista, condannati all’ergastolo, e facenti parte del secondo livello, il comitato ristretto dei capimafia messi al corrente da Riina delle complicità esterne. Loro sanno. Perché nonostante sappiano hanno continuato a tacere?
Perché non vogliono fare la fine di Antonino Gioè e di Luigi Lardo. Anche loro hanno dei familiari. Il suicidio-omicidio di Antonino Gioè nel carcere di Rebibbia è stata una lectio magistralis che ha fatto capire ai mafiosi detenuti che nulla li può salvare rispetto alla capacità di una parte dello Stato di penetrare anche all’interno dei luoghi più protetti come le carceri e di eliminare chirurgicamente coloro che non sanno tenere per sé i segreti che coinvolgono i mandanti e i complici esterni.
Con la parola sistema intendo un sistema composto da due facce dello stato. Uno stato palese, ufficiale, che agisce secondo procedure legalitarie e uno stato occulto, invisibile, profondo, che ha operato con depistaggi e ha operato con interventi chirurgici. Un secondo motivo concorrente con il primo, di autotutela, che spiega il silenzio dei boss stragisti. Essi sanno che i segreti di cui sono a conoscenza per un verso sono come una seconda prigione, ma per altro verso costituiscono un prezioso capitale di scambio con il quale possono contrattare in cambio del loro silenzio, un exit strategy che consenta loro di uscire dal carcere evitando l’ergastolo”.
LA TRATTATIVA STATO-MAFIA
Così dopo la conclusione della strategia stragista i capi condannati all’ergastolo hanno subito iniziato un secondo match. Una lunga trattativa per ottenere modifiche legislative che consentano loro di accedere ai benefici penitenziari, permessi premio, semi detenzione, liberazione condizionale, anche senza collaborare con la giustizia limitandosi cioè a dissociarsi e a deporre definitivamente le armi.
Nel dicembre 1999 venne approvata la legge n.479 che estendeva a tutti gli imputati, compresi i condannati in primo grado per le stragi di mafia, la possibilità di accedere al giudizio abbreviato e di ottenere così la conversione della pena dell’ergastolo in 30 anni di reclusione che grazie al beneficio della liberazione anticipata si riducevano a poco più di 20 anni decorrenti dalla data dell’arresto.
Il 23 ottobre del 2000, Riina, Giuseppe Graviano e altri 15 condannati in primo grado all’ergastolo per la strage del 1993 si alzavano in piedi nelle gabbie della Corte d’Assise d’Appello di Firenze per chiedere l’abbreviato. Soltanto allora dopo le proteste dei magistrati e dei parenti delle vittime il nuovo governo Amato si affrettava a ripristinare l’ergastolo almeno per le stragi. Le trattative segrete riprendevano subito dopo sottobanco.

A novembre del 2001 il magistrato Alfonso Sabella, a capo dell’ispettorato del dipartimento dell’amministrazione penitenziaria, segnalava a Tinebra, che era subentrato a Caselli al vertice del Dap, che Salvatore Biondino, braccio destro e uomo ombra di Salvatore Riina, dopo una serie di colloqui col procuratore nazionale antimafia Vigna aveva avanzato la richiesta di essere mandato a fare lo scopino all’interno del carcere di Rebibbia.
Sabella segnalava che si trattava di uno stratagemma per consentire a Biondino di muoversi liberamente all’interno del carcere e condurre consultazioni con gli altri capi per gestire una linea comune sulla strategia della dissociazione. Il risultato fu che Sabella venne immediatamente rimosso dal suo incarico e il 16 febbraio 2002 gli venne pure revocata la scorta.
La trattativa, secondo Scarpinato, riprendeva il 28 marzo 2002 quando Aieri mandava una lettera al procuratore Vigna lanciando una proposta di consentire un ampio confronto ai detenuti alla ricerca di “soluzioni intelligenti e concrete”. La proposta veniva respinta da una netta posizione della Procura della Repubblica di Palermo.

I BOSS STRAGISTI COMINCIANO A SPAZIENTIRSI
Il 12 luglio 2002 Leoluca Bagarella affermava in una pubblica udienza dichiarando di parlare a nome di tutti i detenuti ristretti nel carcere de L’Aquila, che erano stanchi di essere presi in giro e che le promesse non erano state mantenute. Quali promesse? Fatte da chi? A chi?
Seguiva il 17 luglio un altro proclama dal carcere di Novara firmato da Cristoforo Cannella, componente del gruppo di fuoco di Bagarella, nel quale si accusavano di inerzia gli avvocati di mafia eletti in Parlamento e componenti di commissione legislativa. Dalle note dei servizi segreti viene fuori che si sparge il terrore in alcuni settori della classe dirigente nazionale. Si temono omicidi eccellenti. Chi deve mantenere promesse è chiamato a mantenerle. Nel 2005 alcuni boss mafiosi detenuti al carcere de L’Aquila chiedevano nuovamente di essere autorizzati a discutere tra loro i particolari di una legge sulla dissociazione sulla desistenza.
Negli anni successivi entravano apertamente in campo i fratelli Graviano che iniziavano la loro partita personale. Nel 2009 Filippo Graviano dopo 16 anni di carcere dichiarava che voleva dissociarsi dopo avere fatto sapere al fratello Giuseppe tramite Spatuzza che lo ha riferito che se non arrivava niente, da dove doveva arrivare, era bene che anche loro parlavano con i magistrati. Da dove doveva arrivare quello i Graviano si aspettavano?
Nel gennaio 2020 entrava in campo Giuseppe Graviano nel corso dell’udienza del processo “Ndrangheta stragista” e iniziava a fare dichiarazioni e a depositare memorie con contenuti dirompenti che facevano riferimento in modo criptato ai mandanti occulti delle Stragi che si rivolgevano ad alcuni soggetti che erano in grado di decodificare il significato di quei messaggi.
“È ormai prossima – conclude Scarpinato – la riforma legislativa che abolendo la normativa speciale approvata dopo le stragi consentirà ai boss stragisti di accedere ai benefici penitenziari e quindi alla liberazione condizionale senza collaborare, così come i boss avevano sempre chiesto“.