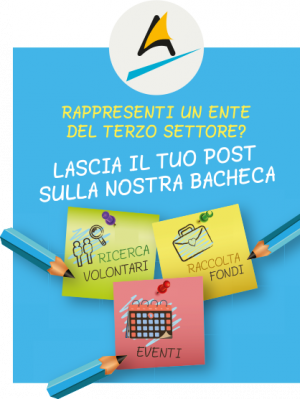CATANIA. La Valle Alcantara da sempre è visitata per le sue gole fluviali ma c’è una parte meno conosciuta ed è quella in alto, compresa tra il feudo Vagliasindi e la Tenuta Rustìca. Un luogo ricco di bellezza naturalistica ma anche storica, si trovano resti archeologici e storici di grande fascino come la chiesetta di Imbischi e la torre di Acqua fredda. Nella zona di Francavilla di Sicilia degli scavi archeologici iniziati negli anni ’90, poi proseguiti nel 2022, hanno portato alla luce un abitato greco ancora senza nome. Una nuova campagna riprenderà nelle prime settimane di giugno.
Alla scoperta dell’itinerario inedito di circa 8 km, che va da Randazzo fino a Rocca Pizzicata, ci accompagna Andrea Orlando, ricercatore dell’astrofisico (PhD), catanese e presidente dell’Istituto di Archeoastronomia Siciliana.
Il percorso seguendo le tracce degli antichi inizia nei pressi del Feudo Vagliasindi, una storica tenuta oggi diventata cantina e hotel di charme. “La dimora nobiliare in stile liberty, interamente restaurata – spiega Andrea Orlando – custodisce un vero e proprio tesoro: uno tra i più grandi palmenti dell’Etna. Uno spazio rimasto intatto, entrarci rappresenta vivere un vero viaggio nel tempo alla scoperta della produzione del vino nell’antichità”.
Si prosegue dal Feudo Vagliasindi, situato in contrada Sant’Anastasia, a pochi km ad Est di Randazzo, da lì inizia una strada inter-poderale che attraversa uliveti, vigneti e antichi casolari. “La trazzera in località Acqua Fredda (zona Imbischi), già in territorio di Castiglione di Sicilia, costeggia i resti di un abitato greco ancora senza nome, come quello presente a Francavilla di Sicilia – aggiunge – questo insediamento fu scoperto in seguito ad indagini archeologiche avviate negli anni 1992 e 1995 dalla Soprintendenza di Catania. Gli scavi degli anni ’90 avevano messo in luce un insieme articolato di ambienti rettangolari, con copertura a tegole e coppi, di varia funzione, la cui ultima fase sembra potersi datare intorno al IV sec. a.C. Nel 2022, grazie ad una nuova convenzione tra la Sop. di Catania e l’ateneo catanese – tramite il Dipartimento di Scienze della Formazione – è iniziata una nuova campagna di scavi e riprenderà nelle prossime settimane”.

Superato quest’area archeologica, nella contrada Imbischi, all’interno di una proprietà privata si possono scorgere i resti diroccati di una piccola chiesa rurale ad unica navata, di cui sono visibili i muri perimetrali e l’abside, mentre manca del tutto la volta di copertura che si sospetta potesse essere a botte o a doppio spiovente. La parte settentrionale presenta due piccole finestre ad elevata strombatura. L’abside, invece, è ancora ben conservato ed è costituito da un catino emisferico in pietra lavica. La chiesetta doveva far parte di un insediamento, molto probabilmente un villaggio rurale che occupava il pianoro e sfruttava i fertili terreni circostanti. Della struttura – aggiunge – se ne interessò anche Paolo Orsi il quale dubitava potesse trattarsi di una costruzione bizantina o normanna, facendo intendere una datazione più tarda, tuttavia è possibile fare dei confronti piuttosto ravvicinati con la cuba di S. Domenica presso Castiglione di Sicilia soprattutto osservando le caratteristiche finestre strombate.
Poco dopo, continuando il cammino sulla trazzera, verso Est, si raggiunge un piccolo edificio con merlature a coda di rondine: è la torre di Acquafredda. La torretta si presenta con una modesta elevazione. Superiormente sono visibili quattro finestre quadrate mentre l’accesso è garantito da un ingresso un tempo sostenuto da blocchi con una piccola volta a tutto sesto. La pianta è quadrata di modesta estensione. Il piano superiore era accessibile attraverso una scala lignea mobile mentre ad oggi è stata sostituita con una permanente. Sono visibili delle saettiere strombate che risultano ad oggi ostruite. Tutta la struttura presenta numerosi interventi di rifacimento e manomissioni avvenuti nel corso dei secoli, tuttavia, conserva ancora gran parte della sua struttura originaria. Riguardo all’origine, sulla base delle osservazioni storiche e sull’architettura, si tratta di una torretta privata per il controllo feudale del territorio risalente presumibilmente tra XVI e il XVII sec. ricadente nei territori appartenenti alla potente famiglia Lanza. Questa torretta doveva sicuramente far parte di un circuito di torri feudali che non solo avevano il compito di controllo e sorveglianza dei possedimenti, ma potevano fungere provvisoriamente da magazzini per lo stoccaggio del raccolto.
Superata la torre si prosegue lungo la Stradella scendendo verso il fiume Alcantara. Per superare il fiume si utilizza una passerella volante costruita per trasportare l’acqua. Giunti a Nord del fiume – prosegue – ci ritroviamo direttamente sulla strada provinciale che da Moio Alcantara conduce a Roccella Valdemone. Si percorre questa strada in direzione Roccella e dopo circa 1 km si giugno al bivio che conduce alla Tenuta Rustìca.
“La tenuta, una tra le più grandi della Valle dell’area di Etna Nord, appartiene alla famiglia Fisauli di Casalgiordano sin dal XVI secolo. Oggi una fiorente azienda agricola coltiva con il massimo rispetto della natura svariate piante da frutto quali pesche, pere, albicocche e ulivi che restituiscono olio extravergine di oliva. Viene inoltre prodotto vino artigianalmente e con amore da viti di 50 anni di nerello Mascalese”.
La Tenuta Rustìca custodisce uno dei siti rupestri più grandi e spettacolari di tutta la Valle Alcantara: è la Rocca Pizzicata. “Questo sito è stato protagonista di uno studio che ho condotto sui siti rupestri della Valle Alcantara, un progetto scientifico e culturale che ha censito i siti rupestri presenti in valle ed ha studiato l’orientamento delle tombe protostoriche. Proprio in cima ad una delle vette della Rocca è presente un grande ambiente a camera, in origine probabilmente una tomba del Bronzo Tardo e Finale poi riutilizzata nel corso dei secoli, fino a diventare un eremo in età medievale”.
Sulla Rocca Pizzicata è possibile osservare anche un misterioso altare rupestre, un probabile secondo altare incompleto, cinque palmenti rupestri (antichi impianti di produzione del vino di datazione incerta) e delle scale intagliate nella roccia. In diverse parti della Rocca sono inoltre presenti delle croci latine intagliate nella roccia, petroglifi che indicano confini territoriali, siamo infatti in una zona di confine tra i comuni di Roccella Valdemone, Santa Domenica di Vittoria e Randazzo.
I palmenti rupestri in particolare rimandano alla produzione del vino nell’antichità, fino ai Greci, secondo alcuni studi ancora prima del loro arrivo a Naxos nell’VIII secolo a.C. Questi antichi impianti di produzione del vino, di datazione incerta, sono manufatti molto interessanti, che si fondono perfettamente con il paesaggio. Destinati alla pigiatura delle uve e alla fermentazione dei mosti, questi massi isolati, nei quali solitamente venivano scavate due vasche comunicanti tra loro da un foro, sono ricavati nella roccia arenaria.
“Secondo un primo censimento – spiega Orlando – svolto nella zona Nord, nella Valle dell’Alcantara, sono stati già conteggiati più di 50 palmenti rupestri. Immersi in un paesaggio mozzafiato, tra l’Etna, il fiume e le dolci colline, i palmenti della Valle Alcantara sono diversi nelle forme e nelle dimensioni. Solitamente queste strutture sfruttavano la conformazione e la pendenza del banco roccioso per la creazione delle vasche, di solito più di due. Ma ci sono esempi che possiedono anche tre vasche. Nella vasca più grande, posta ad una quota più elevata, chiamata ‘pista’, veniva pigiata l’uva, mentre nella vasca inferiore, per la fermentazione, di solito più piccola, ma più profonda, veniva raccolto il mosto. Il liquido defluiva dalla vasca principale alla secondaria attraverso un foro nel tramezzo che metteva in comunicazione le due vasche. In alcuni casi, all’interno delle pareti della ‘pista’ si trovano degli incavi quadrangolari che suggeriscono l’utilizzo di una trave per la torchiatura. Attorno alle vasche, a volte, c’erano dei fori sul pavimento roccioso che permettevano l’alloggio di pali atti a realizzare una copertura del palmento. Il vino che andava a depositarsi nelle vasche secondarie, utilizzate per la fermentazione e la conservazione, veniva poi travasato in contenitori di ceramica per essere distribuito. Ma la Rocca è famosa anche per le sue ‘sfere litiche’, la geologia del sito infatti è legata al Flysch di Capo d’Orlando, rocce di arenaria che possiedono caratteristiche uniche nel loro genere, sia per particolari processi di erosione che di formazione. Il fiume e la valle Alcantara custodiscono tesori naturalistici, storici ed archeologia di grandissimo valore – conclude – è necessario un maggiore sforzo per tutelare e valorizzare questi luoghi”.