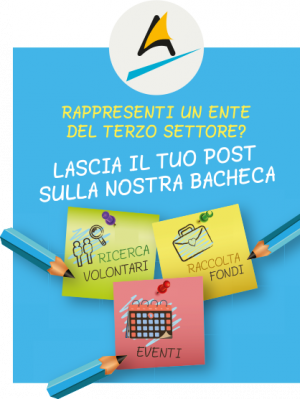PALERMO. L’importanza ed il valore di essere persone in relazione deve stare al centro della nostra vita nonostante la società inviti continuamente all’esercizio pieno del nostro individualismo. A partire da questo pensiero di fondo, ieri pomeriggio, nella sede dell’istituto Pedro Arrupe, si è svolto il primo incontro di GenerAzioni, il nuovo percorso di formazione socio-politica.
A confrontarsi sul tema “Nel caos della complessità, una visione di futuro. Quale politica possibile?” sono stati il sociologo Mauro Magatti, la sociologa dei processi culturali Chiara Giaccardi e il gesuita e docente di filosofia Secondo Bongiovanni.
“Oggi dobbiamo valorizzare tutto ciò che ci umanizza senza dare assolutamente nulla per scontato – afferma il direttore dell’Arrupe Gianni Notari s.j. -. GenerAzioni è nato proprio per capire insieme quali strade percorrere nel quadro di un rinnovamento politico e sociale. Per questo, dopo vent’anni, riparte la formazione socio-politica, nata da p. Bartolomeo Sorge nel 1986″.
“Nessuno può dire chi e che cosa sarà l’uomo nel futuro – dice Secondo Bongiovanni, gesuita e docente di filosofia presso la Facoltà teologica meridionale di Napoli -. Oggi le sfide che dobbiamo affrontare sono tre. Il primo è il passaggio dalla sostanza alla relazione. Noi passiamo dal paradigma della sostanza fissa ad una rete infinita di relazioni e di interconnessioni tra di noi e nel mondo.
La seconda grande sfida è quella di passare dalla egologia alla ecologia. E’ il passaggio da una comprensione del mondo a partire dall’ego a una comprensione dell’ego stesso a partire dal mondo, dall’oikos cioè ecologia che significa casa. La terza sfida è, infine, quella di passare dalla coscienza a quella dei neuroni/algoritmi. Sempre più nelle neuroscienze, si tende a ridurre l’uomo a puri meccanismi neuronali. Abbiamo bisogno di queste scienze ma è in gioco l’uomo come essere libero nella dimensione più spirituale cioè della sua coscienza”.

“Stiamo entrando in una stagione storica di cui nessuno ha le mappe – spiega Mauro Magatti, ordinario di Sociologia generale presso l’Università Cattolica del Sacro Cuore di Milano -. Nei trent’anni di globalizzazione che ci lasciamo alle spalle, è stata espressa l’idea potente che la crescita economica fosse uguale all’aumento delle possibilità di vita moltiplicato per miliardi di individui.
Il pensiero di fondo era che tutto si espandeva e tutto cresceva. Tutto ciò, ha creato un enorme effetto entropico sia per quanto riguarda l’ambiente che per quanta riguarda la dimensione psichica e quella relazionale. In un mondo in cui tutto si espandeva tutto però si slegava. Oggi è ragionevole continuare a pensare in questo modo? Direi di no, non ce la facciamo perché siamo tutti in relazione e le risorse sono finite.
Tutto è relazione, nel piccolo e nel grande in termini geopolitici. Le grandi tradizioni devono comprendere come stare in relazione nel mondo. Due sono i grandi driver che ci accompagneranno per i prossimi decenni. Il primo è la sostenibilità cioè il percorso di consapevolezza del nesso tra il nostro modello di vita economico-sociale e la questione dell’ecosistema.
L’altro è la digitalizzazione che è un fenomeno gigantesco. Dopo la globalizzazione siamo entrati nella supersocietà che ci conduce ad affrontare la tecnosfera (dimensione economica), la biosfera (questione climatica, demografica e migratoria) e la noosfera (la formazione del pensiero e conoscenza). Questi tre aspetti si devono affrontare contemporaneamente in tutto quello che sarà il futuro impegno politico”.
“Ci sono tre parole che occorre condividere insieme – afferma Chiara Giaccardi, ordinaria di Sociologia dei processi culturali e comunicativi presso l’Università Cattolica del Sacro Cuore di Milano -. Le tre parole da sottoporre ad una critica costruttiva sono: identità, libertà e cura. Identità è una parola pericolosissima che ha scatenato guerre. E’ un costrutto statico, oppositivo che si costruisce in contrapposizione ad un altro.

Occorrerebbe parlare più di individuazione: un processo dinamico che ci fa prendere forma in relazione a ciò che è altro da noi. La libertà come idea generativa è quella di fare esistere con altri e per altri ciò che ancora non c’è. Questo tempo ci chiede la creatività ed il coraggio di impegnarci per ciò che ancora non c’è. Oggi ci viene chiesto un esercizio di libertà che ci pone continuamente in relazione.
E poi c’è la cura. Noi ci dobbiamo prendere cura di questo mondo che è entropico, frammentato e ferito. Allo stesso modo, dobbiamo prenderci cura del pensiero che è sempre più mortificato. La cura è una dinamica di reciprocità dentro cui ci si trasforma andando oltre la prigione del proprio io. La cura è prima di tutto un modo di guardare il mondo. E’ ciò che amiamo che ci fa diventare chi siamo. Se abbiamo imparato a guardare ed ad amare nasce la terza dimensione della cura come impegno che riguarda anche la nostra dimensione politica”.