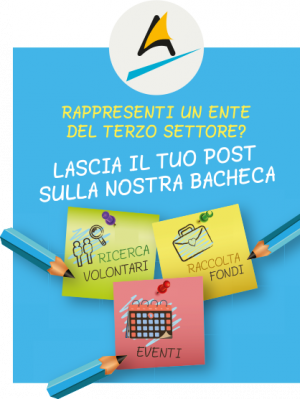di Antonella Lombardi
PALERMO
Oltre il 90% delle aziende confiscate nel nostro Paese sono destinate a essere liquidate e la Sicilia, con il 32,70%, è la regione con la percentuale più alta di aziende in confisca definitiva. È il primo dato allarmante che emerge dal libro di Rosa Laplena “I beni confiscati alla criminalità organizzata”, Mediter edizioni, che analizza le cifre fornite dall’Agenzia nazionale dei beni sequestrati e confiscati (ANBSC) insieme al quadro normativo di riferimento.
“Un mafioso senza beni è come un re senza scettro”, ha scritto Luciano Violante negli atti della commissione parlamentare antimafia del 1992/94 citata dall’autrice per spiegare il senso della legge sul riuso sociale dei beni, cioè la destrutturazione del sistema mafioso.
Tanti, però, sono i punti critici emersi dall’analisi di Laplena che non fa sconti al sistema vigente, partito dall’intuizione di Pio La Torre e culminato nell’approvazione della Legge 109/96, nota come Rognoni – La Torre, approvata in uno dei momenti di alta tensione emotiva nella lotta a cosa nostra, successiva all’omicidio prima del deputato La Torre e poi del generale Dalla Chiesa.
Dal mancato o parziale coinvolgimento del terzo settore, all’incapacità di esprimere un modello “che permetta la ricollocazione delle aziende confiscate sul mercato”. Tradendo, come scrive nella prefazione Giuseppe Di Lello, magistrato che ha fatto parte del pool antimafia istituito da Rocco Chinnici, il principio ispiratore della stessa legge, per cui paradossalmente si penserebbe che “La mafia dà lavoro, mentre lo Stato lo toglie”. Tra i mancati propositi, Di Lello, promotore della legge 109, suggerisce per la gestione l’istituzione dei fondi provinciali derivanti dai sequestri o dalla vendita dei beni mobili, originariamente previsti dalla stessa legge.
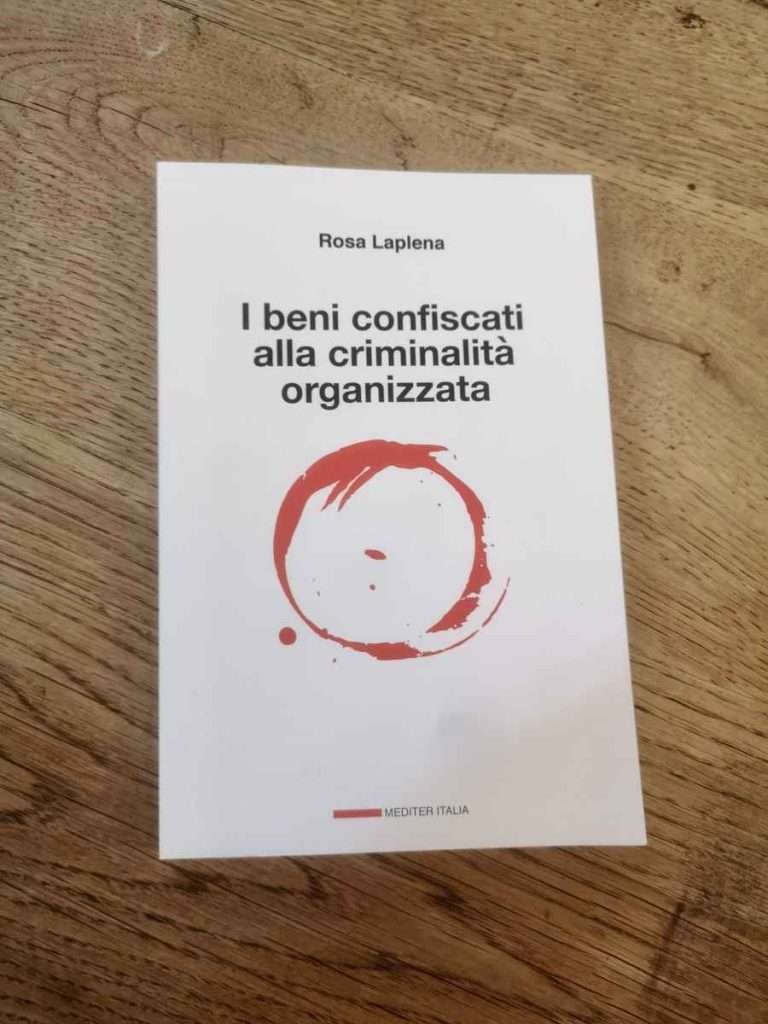
Entrando nel merito dei dati riportati da Laplena, se si prende in esame il decennio che va dal 31 dicembre 2011 al dicembre 2021, all’Agenzia nazionale sono stati destinati 8817 beni immobili confiscati, mentre, solo nel 2021, sono stati 1988, pari al 22,57% del totale delle destinazioni del decennio. Un risultato raggiunto, secondo Laplena, grazie alle ultime modifiche legislative al codice antimafia. La Sicilia, con 391 Comuni, di cui 208 interessati alla destinazione dei beni confiscati, ha il dato più alto con il 53,20%, praticamente più della metà dei Comuni dell’Isola. Nel dettaglio, il Comune di Palermo ha il maggior numero di beni confiscati, circa il 30% del totale siciliano. Nel capoluogo, però, si registra una criticità importante, dovuta al criterio della trasparenza: vige infatti un regolamento che prescrive che allo scadere delle convenzioni il bene venga rimesso a bando. Questo ha creato diverse interruzioni di attività e disagi soprattutto nel settore socio-sanitario. Nei fatti, il coinvolgimento dei soggetti del terzo settore è stato lasciato alla discrezionalità dei Comuni. Secondo i dati del volume, in percentuale il terzo settore gestisce in tutto il 4,9% dei beni immobili destinati, mentre le cooperative appena l’1%.
“La riuscita dei progetti promossi da Libera – dice Laplena – prevede una concertazione tra pubblico e privato che include enti locali, privato sociale, associazioni, prefetture, istituzioni”. Con ricadute importanti sul mondo del lavoro, stando allo studio riportato da Confcooperative che ha analizzato 153 cooperative, su un totale di 198, che gestiscono beni confiscati: le 153 coop danno lavoro stabile a oltre 11mila dipendenti, con un valore aggiunto aggregato di 230 milioni di euro (e un valore medio di 418mila euro). Ma le lacune maggiori del sistema riguardano le aziende: a partire dalla nomina di un esperto aziendale che spesso non avendo una visione complessiva dell’azienda, è più un custode/contabile attento agli aspetti formali.
Per quanto riguarda le aziende confiscate, secondo i dati ANBSC la Sicilia è la prima regione, e se la Lombardia supera di poco la Calabria, con il 9,74% (rispetto al dato calabrese di 9,36%) questa è comunque la prova che le mafie sono pronte e capaci di infiltrarsi nelle regioni più ricche. Il settore principale è quello delle costruzioni, pari al 25% del totale, ma va segnalato che anche se in minima percentuale, cioè 1,7%, le mafie si sono infiltrate pure nelle aziende che erogano la distribuzione di servizi primari, come acqua, luce e gas. A decretare la morte repentina delle aziende – al netto di quelle recuperabili e non drogate dalle dinamiche mafiose di riciclaggio – è la sospensione prevista dal codice antimafia dei contratti pendenti, che paralizzano l’azienda anche con le commesse già in carico. Inoltre, prevedendo la possibilità di saldare i creditori dalla prima fase del sequestro, l’impresa esaurisce subito le risorse economiche disponibili, prima ancora di poter essere rilanciata sul mercato e prima ancora di applicare un piano di conversione industriale.
Per uscire dalle storture del sistema, Laplena propone diverse strategie, come l’istituzione di un “fondo di garanzia per le spese attingendo al Fug”, rating di legalità, convenzioni che diano il diritto di prelazione nelle commesse alle aziende confiscate o forme di “incentivi e tutoraggio per regolarizzare i rapporti di lavoro in nero e tutelare la sicurezza degli impiegati”. Purché si ritorni al senso dell’importanza di sottrarre quello scettro ai mafiosi per restituire alla collettività un bene utile a tutti.